In altre parole
In other words
Intervista a Vincenzo Cerami
In passato hai dichiarato che l’arte di scrivere non è altro che l’arte di raccontarsi attraverso il linguaggio.
Voglio raccontare a questo proposito una cosa molto personale e cioè come ho scoperto la scrittura, perché un bel giorno ho deciso di diventare uno scrittore. Da bambino ho avuto alcuni handicap fisici da cui per fortuna sono guarito nel tempo. Ma a dieci anni, ero veramente nevrotico e afasico. Ero disadattato e stavo sempre da solo. Tuttavia non ero triste in quella mia solitudine, anzi. Per farmi compagnia mi raccontavo delle storie, magari mentre passeggiavo per Ciampino; inventavo trame in cui il protagonista ero sempre io: un tipo avventuroso che aveva sempre la meglio, un vero mito. Chiaramente partiva tutto dalla mia immaginazione più intima e quando in una particolare circostanza ho rivisto un atteggiamento simile in mio figlio bambino, la cosa mi ha impressionato e riportato indietro. Alle scuole medie c’è stato l’incontro con Pasolini, per tre anni il mio professore di lettere. In quel giovane insegnante di soli ventotto anni, vestito come noi anche se era tenuto a portare la cravatta, tutta lisa perché era povero – e già solo questo ce lo faceva sentire più vicino rispetto agli altri insegnanti – proiettai tutto il mio desiderio di salvezza. Forse, chissà, avvenne una specie di transfert con la figura di mio padre. con Pasolini ho voluto e cercato un contatto, ho cercato di raccontarmi. Avrei voluto dirgli che non ero né afasico né nevrotico. Ma stavo seduto all’ultimo banco per nascondermi e non rispondevo nemmeno all’appello. Volevo dirgli delle cose, ma come potevo fare? Era il professore di tutti, non il mio psicanalista. Una mattina però arrivò l’occasione: assegnò alla classe un tema libero – quelli che non si danno più a scuola, anche se pare sia un’abitudine che sta tornando – la cui traccia era Una domenica in montagna, senza chiedere se qualcuno di noi era realmente stato in montagna. Io mi misi a scrivere sul mio quaderno grande, che lui ci chiedeva di usare e che chiamava “il quaderno dei riflessi condizionati”. E così cominciai, provando un’emozione che mi prende ancora quando ricordo quel momento: era arrivata l’occasione per parlargli. Finalmente saremmo stati soli, io e lui. E anche se in realtà non sarei stato fisicamente di fronte a lui, lo avrei raggiunto attraverso la pagina scritta.
Il tema, però, non era parlami di te, ma una gita in montagna. Però in maniera indiretta, parlando d’altro, gli avrei comunque comunicato qualcosa di me (senza sapere esattamente cosa). Inventai allora una storia che si svolgeva sul Terminillo, in cui ero io il protagonista, forte e sicuro di sé, che affrontava vittoriosamente yeti, serpenti e valanghe e che dominava la situazione padroneggiando il mondo. La notte non riuscii a dormire all’idea di quello che avrebbe potuto pensare di me: che ero un pazzo, un mitomane. E allora lo riscrissi completamente, forse trovando così la mia poetica. Lo ambientai in una domenica d’estate, con le cacche delle mucche, i tafani… esprimevo una noia mortale, con l’aggiunta di scene un po’ comiche, perché sapevo che a lui piaceva ridere. Lo arricchii di dettagli per far sembrare che ero stato veramente al Terminillo, anche se non era vero. fu in quell’istante che iniziai a scoprire la letteratura. La fortuna volle che Pasolini leggesse il mio tema camminando tra i banchi, a voce alta. Mi sorpresi non poco, mi emozionai e fui felice, tanto da non vedere l’ora di poter scrivere il tema successivo. Da quel giorno, fino ad oggi – fino a venti minuti fa – non ho fatto altro che scrivere temi liberi; prima in letteratura, poi in poesia, in prosa, per il cinema, per il teatro e con i fumetti. cos’era in fondo per me la letteratura? Era riuscire a parlare di me: raccontarmi, raccontando però altro. Poi però, appassionandomi e scoprendo in me un certo talento per la narrazione e per la costruzione di storie, ho imparato che, per farlo meglio e per raccontarmi in maniera più “giusta”, dovevo conoscere di più gli altri. Insomma, iniziavo a realizzare che il mondo nel quale mi calavo non doveva e non poteva essere bidimensionale, ma più complesso. Così, a un certo punto, la mia curiosità si è concentrata totalmente sull’esterno e questo mi ha poi consentito di tornare su di me in maniera più matura, per potermi fotografare meglio. Con il passare del tempo la mia passione più autentica è diventata proprio l’interesse per gli altri, non più per me stesso. Così è cresciuta la curiosità e la voglia di viaggiare, di fare dei lunghi viaggi stando fermo. Oggi posso dire che è molto più esaltante la stanzialità, viaggiare con l’immaginazione piuttosto che viaggiare realmente. a onor del vero ho anche avuto la fortuna di visitare molti luoghi lontani. Ricordo a tale proposito quando mi chiesero di tenere una trasmissione radiofonica intitolata Viaggi a memoria, durante la quale avrei dovuto rievocare per gli ascoltatori i viaggi che avevo fatto nella mia vita. accettai. E siccome si trattava di due trasmissioni a settimana, dopo un po’ i viaggi effettivamente fatti si esaurirono. Così dovetti inventarne altri: raccontai luoghi dove non ero mai stato, ma che avevo visitato con l’immaginazione. paradossalmente proprio i resoconti di questi ultimi furono molto apprezzati, perché rispetto a una descrizione oleografica della realtà risultarono più espressivi, veri.

Raccontare, secondo me, significa raccontare se stessi raccontando altro. Ma il punto è che per far questo è necessario conoscere l’altro. senza voler entrare nel merito della qualità del mio lavoro, penso di essere stato negli ultimi tempi lo scrittore più prolifico di storie: ne ho prodotte tantissime per ogni mezzo espressivo che ho usato. Perciò, rispetto alla distinzione che fa Walter Benjamin, mi sento più un narratore che uno scrittore vero e proprio.
Ho usato la parola in tutti i modi possibili e in tutti i paradigmi espressivi e comunicativi possibili. Il racconto letterario è uso della parola scritta, in silenzio. È composto perché un’altra persona lo legga in silenzio.
Attraverso questa misera tecnologia – carta e penna – dovevo riuscire a descrivere i visi, gli ambienti, rendere l’anima delle persone, far vedere le cose, far sentire gli odori, far immaginare tutto. La scrittura è l’unica arte che si crea in solitudine: mentre scrivo penso che ci sia davanti a me una sola persona. Anche la retorica è particolare, perché se parlo a un unico lettore mi confesso, divento spudorato, chiedo complicità, pietà: c’è insomma un chuchoter indirizzato a una sola persona. In altri usi della parola, come nel caso del cinema o del teatro, c’è un’intera platea e la retorica si modifica. La letteratura con le sue parole silenziose è l’arte più povera da un punto di vista tecnologico. Ma più l’arte è povera, maggiore è la sua potenzialità espressiva: senza altri strumenti all’infuori della penna, soltanto con le parole scritte in silenzio, devo riuscire a far vedere tutto. Nel cinema invece ho le immagini, posso passare da un ambiente all’altro e rappresentare il trascorrere del tempo servendomi delle convenzioni tipiche del linguaggio cinematografico. Il teatro ha un linguaggio ancora diverso: basti pensare che lo spettatore sta fermo e ha davanti a sé un’inquadratura fissa. Al cinema lo spettatore in realtà non sta seduto, viaggia: nel caso di un primo piano è come se si trovasse a un metro dal soggetto ripreso, ma quando il soggetto viene inquadrato in lontananza anche chi guarda si è allontanato, e se la ripresa è quella di un uomo in corsa è come se anche lo spettatore corresse. Se scrivo una sceneggiatura sono consapevole del fatto che sto lavorando con il linguaggio delle immagini, perciò quello che mi interessa è l’azione: è attraverso la descrizione dell’azione che devo riuscire a raccontare ciò che in letteratura sarebbe affidato soltanto alle parole. Tuttavia la letteratura permette di raccontare ciò che le altre forme narrative non possono raccontare: se in letteratura si può entrare nel pensiero di qualcuno, nel cinema si può soltanto cercare di mettere i personaggi in una situazione fisica in cui – attraverso le loro azioni, il loro modo di muoversi e di confrontarsi – si può dedurre cosa stanno pensando, per quale preciso motivo compiono certi gesti. Così accade che, in una sceneggiatura cinematografica, tramite la parola evoco un altro linguaggio: il linguaggio del cinema. Lo stesso avviene nel teatro: prendiamo per esempio l’Amleto di Shakespeare. a partire dal testo originale sono state fatte milioni di rappresentazioni, tutte diverse l’una dall’altra, a tal punto che quando lo andiamo a vedere a teatro non è più l’Amleto di Shakespeare, ma una trasposizione dal linguaggio scritto di Shakespeare, a una sua rilettura con le convenzioni del linguaggio teatrale. Se pensiamo invece alla poesia potremmo ricorrere al termine moderno format, è fondamentale la sua morfologia, il modo in cui è fatta. E la poesia è un susseguirsi di versi che in genere sono legati da una relazione fonetica. Così se voglio scrivere una poesia su un tema, comincio a scrivere il primo verso che contiene in nuce più o meno quello che vorrei dire, per poi passare al secondo che però deve essere scritto rispettando le regole del format in cui si inscrive. Il problema si pone con il verso successivo perché, oltre a rispettare la struttura generale, può o deve essere in rima: così si avvia il processo mentale per cui richiamo alla mente tutte le possibili parole che finiscono in un certo modo e le seleziono, ricercando quella più aderente alle mie intenzioni. La sorpresa sta nel fatto che la trovo, ma non è quella che cercavo: finisco per scegliere una parola che ‘sento’ giusta, che fa deragliare… ma è stata la creazione di quel testo poetico che mi ha fatto scrivere quella parola. È la struttura linguistica stessa dei versi ad aprire finestre verso orizzonti che altrimenti non potremmo raggiungere. In prosa si può stabilire una scaletta e decidere a priori cosa scrivere, in poesia l’opera nasce mentre si scrive e non si può prevedere in anticipo. La poesia è scoprire il mondo attraverso la scrittura, è andare oltre l’apparente: è un processo che è il risultato di un fatto puramente formale. Adottando una struttura poetica (l’endecasillabo, il sonetto, la rima baciata, etc.) è come se scegliessi di imprigionarmi da solo, ma per avere poi la possibilità di scoprire in corso d’opera un senso, un risvolto inatteso, che non avrei potuto conoscere e prevedere prima.
Nel teatro, invece, il modo di parlare deve essere di cartone per preservare una sua coerenza semantica. Mentre il parlato del cinema è quello della quotidianità, quello teatrale non è adatto alla vita di tutti i giorni, va bene solo per il palcoscenico. Allo stesso modo, anche la parola intrecciata alla musica usa forme verbali che in altri contesti sarebbero quanto meno discutibili, mentre nell’ambito di una composizione musicale risultano invece sublimi. In conclusione, la parola non è sempre se stessa: la parola cambia di segno a seconda del sistema linguistico in cui si inserisce e si trasforma in base alle funzioni che deve assolvere.

Che rapporto c’è tra “l’indicibile” e le parole scritte, tra il silenzio e la comunicazione?
Faccio questo esempio: noi quando pensiamo non pensiamo con le parole, non costruiamo un discorso con soggetto, predicato e tutto il resto. Pensiamo invece attraverso un vocabolario fatto di sentimenti, turbamenti, emozioni. Il nostro pensiero interiore è continua associazioni di idee o – come direbbe Pavlov – di impulsi e scariche elettriche, di colori e campi magnetici, di sensazioni immediate e di memorie accumulate. Se mi domandi cosa sto pensando, ti esprimi in italiano; perciò, per risponderti, prenderò il vocabolario italiano e la sua sintassi per cercare di dar parola, ovvero di verbalizzare, un qualcosa che parola non ha. Per comunicarti quello che ho in testa, o le emozioni che sto provando, dovrò azionare un meccanismo che, in un certo senso, è paragonabile a quello di una macchina. Paradossalmente, per riuscire a dirti quello che sto davvero pensando dovrò dirti una bugia, solo in quel modo potrò comunicare. Perché se ti dicessi esattamente quello che mi gira in testa, te lo direi male, finirei per esprimermi in maniera tanto confusa da risultare incomprensibile.
Per dirtelo dovrò rinunciare alla pretesa di essere del tutto fedele al mio vero pensiero, potrò solo avvicinarmi alla verità attraverso un giro di parole. E per me l’arte è proprio questo: mettere la parola dove non c’è, far parlare il nostro silenzio. se riflettiamo, la maggior parte di noi parla al massimo un’ora e mezza o due al giorno, non di più. Tutto il resto della giornata lo passiamo in silenzio. Ed è in silenzio che prendiamo decisioni, viviamo turbamenti, amiamo qualcuno ed elaboriamo un lutto. La vera vita è lì e parla un linguaggio che non è fatto di parole. L’arte è allora una forma essenziale della comunicazione, quella che Moravia chiamava “la messa in scena del rimosso di una società”.
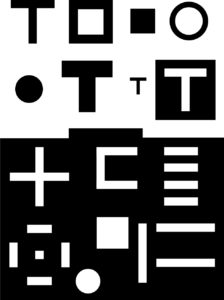
Molti nel secolo scorso avevano profetizzato l’estinzione della parola scritta per effetto delle nuove tecnologie di comunicazione. Di fatto, oggi scriviamo e leggiamo forse di più che nel passato recente. Ma il racconto di sé fatto attraverso sms, post su Facebook o cinguettii su Twitter non rischia di essere, più che autentica narrazione, un elenco di didascalie a un’immagine simulata, ad uso e consumo di un’identità desiderata e desiderabile?
Rispetto a un passato anche piuttosto recente, oggi disponiamo di una quantità sempre maggiore di mezzi di comunicazione. Ho sempre avvertito e vissuto questa crescita dei dispositivi tecnologici di comunicazione come un’ansia di comunicazione: è come se inventassimo sempre nuovi mezzi per comunicare perché non riusciamo davvero a comunicare e quest’insuccesso provoca in noi ulteriore ansia. Effettivamente non c’è comunicazione. Tralasciando riflessioni di natura sociologica, anche soltanto da un punto di vista strettamente linguistico mezzi come l’e-mail o i blog producono l’esatto contrario della comunicazione. Chiunque scriva lo fa lavorando necessariamente con una materia esterna a sé e autonoma: il sistema linguistico della parola. Tutto – o quasi – può essere scritto, ma deve essere organizzato secondo certe regole. perciò chi scrive deve conoscere la “macchina” per poterla governare, altrimenti è la macchina a condurre il gioco. Molti ragazzini passano ore davanti al pc a raccontarsi, più o meno consapevolmente. Infatti ci raccontiamo scrivendo di qualsiasi cosa: anche se non lo vogliamo, il modo stesso in cui scriviamo – comunque – ci sta già raccontando. Così, anche quando comunichiamo in tempo reale con qualcuno che magari è dall’altra parte del mondo, diamo di noi un’immagine, ci sveliamo. In realtà non raccontiamo noi stessi ma il mito di noi stessi, ovvero, l’immagine che abbiamo di noi. Non c’è bisogno di scomodare Freud per capire che le cosiddette autobiografie non esistono, perché in ogni caso si tratta di invenzioni che obbediscono alle regole della letteratura e del linguaggio. E la menzogna fa parte del linguaggio. Quindi succede che mi racconto per ore attraverso gli attuali mezzi tecnologici, costruendo un’immagine di me in cui mi identifico finché sono connesso. poi, una volta interrotta la comunicazione, torno me stesso: il mistero. Quando però torno nuovamente on line devo recuperare tutto il terreno perduto, ritrovare quella forma di contatto con me stesso e, pian piano, succede che mi riconosco solo attraverso quell’immagine. Al di fuori sono smarrito, non ritrovo una mia identità. In assenza di una distanza critica, tutto questo rischia di creare pericolose forme di dipendenza e, a lungo andare, di farci spingere il pedale della virtualità fino farci esplodere. La parola non ha mai avuto tanto potere quanto in questo periodo. proprio perché è rimasto l’unico mezzo con cui puoi far passare un pensiero e non solo un’emozione. Tutti gli altri sono linguaggi iconici. Credo sia una necessità dell’uomo poter comunicare ed esprimere le complessità, non soltanto le emozioni. L’emozione, dopo un po’, stufa. Ma dobbiamo comunque fare una distinzione: c’è parola e parola, è necessario contestualizzare. In una trasmissione politica televisiva, la parola è manipolata dal contesto. Una volta scrissi una lettera a Fassino, allora segretario del partito Democratico, facendogli notare che quando aveva parlato nel programma di Bruno Vespa, dietro di lui campeggiava uno schermo con il direttore del Tg4, Emilio Fede, che gli faceva anche il verso. Lì c’era stata tutta la sapienza di un giornalista come Vespa nell’impostare la ripresa della trasmissione. In televisione le ragioni non contano: si può dire qualsiasi cosa, ma nessuno presterà la dovuta attenzione. Durante il confronto televisivo finale “uno contro uno” della tornata elettorale vinta poi da prodi contro Berlusconi, l’assegnazione delle due poltrone nello studio venne tirata a sorte. Infatti, chi siede a sinistra è avvantaggiato rispetto a chi sta a destra perché appare per primo sullo schermo. E, naturalmente, nessuno dei due voleva occupare il posto del perdente.

La tua è una scrittura totale: prosa, poesia, radio, cinema, teatro, fumetto, musica…
Ho cominciato scrivendo per il cinema e per il teatro, due mondi scoperti grazie a Pasolini. E oggi, credo davvero che non mi sia rimasto più niente da provare! Mi sono confrontato con il giornalismo, la saggistica, la narrativa, la poesia.
Ho usato la parola anche per scrivere testi di canzoni e di opere liriche. penso che anche il linguaggio radiofonico sia straordinario: la radio è un mezzo tecnologicamente complesso ma linguisticamente molto povero. Quando scrivo per la radio devo rivolgermi soltanto all’organo dell’udito: non racconto semplicemente una storia, devo metterla in scena per far entrare l’ascoltatore in un mondo tridimensionale fatto di voce, di suoni e di rumori. Per paradosso, il cinema è come se fosse stato inventato per i non udenti – tant’è che nasce muto – mentre la radio è come se fosse destinata ai non vedenti. Il fumetto è stato l’ultimo linguaggio in ordine di tempo che ho sperimentato. E mi dispiace, perché avrei voluto scoprire molto prima questo spazio straordinario. Lavorare con disegnatori come Milo Manara o Silvia Ziche è stata davvero una bellissima esperienza.
E che vincoli impone la scrittura di un musical?
Il musical è comunque una forma di teatro: è teatro musicale, come l’opera lirica. Anzi possiamo dire che l’opera lirica sta all’Italia come il musical sta ai paesi anglosassoni. È una forma espressiva che deve rispettare contemporaneamente sia le regole del teatro che quelle della musica. Nel teatro cantato il racconto è fatto a quadri e bisogna essere bravi a far capire la situazione senza l’aiuto del parlato e dei dialoghi, consapevoli anche del fatto che il più delle volte le parole cantate non vengono comprese con precisione. Perciò la parola cantata deve essere espressiva, più che comunicativa: non devono essere cantati fatti ma sentimenti come l’amore, il dolore, il cordoglio, l’amicizia, il tradimento. Tanto che l’intreccio è sempre molto paradigmatico e semplice, giusto pretesto per volare sui grandi temi.
Come hai vissuto la trasposizione cinematografica del tuo romanzo Un borghese piccolo piccolo nel film diretto da Mario Monicelli?
Il libro era abbastanza adatto per trarne un film, perché già visivo di per sé e la storia era molto cinematografica. Come ho già detto, diversamente che in letteratura dove la storia è soltanto un pretesto per poter raccontare altro, nel cinema si è interessati proprio alla storia. Non ho firmato la sceneggiatura del film, ma solo dato qualche consiglio. Ovviamente la trasposizione cinematografica ha richiesto dei cambiamenti. Nel cast del film c’era l’attrice americana Shelley Winters e per valorizzare la sua presenza fu inventata la scena in cui il suo personaggio viene portato a vedere l’assassino. Alla fine del libro il protagonista, ormai in pensione, sta seduto su una panchina immerso nei suoi pensieri, a contare agli anni che gli rimangono davanti. Questo flusso interiore difficilmente si sarebbe potuto rendere al cinema e così il film si conclude con il protagonista che impazzisce e diventa una specie di mostro. In quell’occasione chiesi consiglio a Sciascia, che era abituato a cedere i diritti dei suoi libri per la realizzazione di film, e lui mi disse che non mi dovevo porre il problema della fedeltà al testo originale, perché il cinema ha altri linguaggi e il risultato della trasposizione non potrà che essere un’opera diversa. Del libro interessa la storia. E la storia è l’aspetto che invece interessa di meno allo scrittore.

Vuoi parlarmi dell’impresa di scrivere sceneggiature cinematografiche?
Il film lo si vede già mentre lo si scrive. La sceneggiatura prevede fin dall’inizio certe scelte registiche e in qualità di sceneggiatore discuto sempre le inquadrature con il regista. Di fatto, il copione è quasi il film scritto per inquadrature. È un aspetto che conosco bene perché da ragazzo ho scritto molte sceneggiature per le produzioni americane e per ogni scena dovevo specificare l’inquadratura. Nel caso di un film tratto da un libro, torno a dire che per forza di cose la sceneggiatura deve apportare delle modifiche al testo originale. Un film deve essere fedele al libro da cui è tratto, ma per essere tale deve essere infedele alla lettera. Quello che conta è che venga rispettato lo spirito dell’autore e in un film come il pinocchio che ho sceneggiato per Benigni credo che lo spirito di collodi ci sia tutto. Molto più che in altre versioni cinematografiche come, ad esempio, quella di Comencini: lì Pinocchio passa più volte dall’esser burattino di legno a bambino in carne e ossa, a seconda del suo comportamento. Niente a che vedere con lo spirito originale del libro, la storia più noir mai scritta in Italia. Il vero pinocchio è la storia di una violenta macchina repressiva: il protagonista viene legato a una cuccia come un cane, trasformato in un somaro da soma, derubato, mandato in galera, ucciso. Subisce una lunga serie di prove tremende, per poi diventare un piccolo borghese. Di certo non è un romanzo per bambini. In effetti, Pinocchio era nato come un breve un racconto pedagogico destinato alle pagine di una rivista, una storiella didascalica per insegnare ai bambini l’importanza dello studio e della scuola. Visto il successo riscosso dal personaggio, l’editore chiese a collodi di continuare la storia. Così il burattino che era finito impiccato viene riportato in vita dalla fata turchina. capitolo dopo capitolo, la storia sfugge di mano a collodi: il risultato finale non è un libro organico, ma una lettura che solleva domande e interrogativi come: chi è davvero il cattivo? Pinocchio o gli altri? La giustizia del mondo è quella che mette in galera un innocente? E così il libro diventa un capolavoro, che non si conclude con il classico “e vissero tutti felici e contenti” ma con un finale meraviglioso. Diventato un bambino vero, pinocchio guarda il burattino morto e dice: «Com’ero buffo, quand’ero burattino! e come son contento di esser diventato un ragazzino perbene!». Pinocchio ci lascia con un dolore immenso, con tutta la malinconia di chi vede se stesso morto. con quel burattino è morta l’infanzia, il principio del piacere. Pinocchio è diventato grande: ha imparato cos’è la sofferenza e l’abnegazione, ha scoperto cos’è la civiltà. Non rincorre più le farfalle, deve stare alle regole.
Alcuni ti hanno definito un neo-funzionalista perché riesci ad esercitare l’arte della scrittura anche partendo da una traccia già data, magari su commissione…
Se come te fossi un designer, il mio maestro sarebbe Philippe Starck: un vero funzionalista, capace di progettare di tutto rispettando bisogni e richieste del committente. Il sapere dell’artigiano è l’aspetto dell’artista che più mi interessa. Come accadeva nelle grandi botteghe del Rinascimento, ogni artista deve essere prima di tutto un artigiano: se non conosce quali sono i materiali con cui deve trattare una tela prima di dipingerci sopra, è inutile che si metta a fare il pittore. Ho studiato approfonditamente e pubblicato alcuni saggi su Tolstoj, grande maestro di narratologia, il quale spiegava che per poter scrivere è fondamentale la giustapposizione degli elementi. come dire: conosci il mezzo che usi. Raymond Carver spiegava così la differenza tra chi scrive e chi è scrittore: per scrivere basta conoscere una lingua ed eventualmente disporre di qualcuno che ci corregga la forma; per essere uno scrittore bisogna possedere un punto di vista. È tutto un problema di angolazione. Il punto non è scrivere, ma produrre letteratura. Ed è la coscienza linguistica che fa la letteratura. Questo me lo insegnò Calvino, con cui ne parlai a lungo. Diceva che lo scrittore è colui che ha coscienza linguistica. In tanti scrivono, ma pochi fanno autentica letteratura, perché in pochi conoscono la materia e le sue leggi. Ma, attenzione, non è la bella scrittura che fa la letteratura. Non si tratta di indossare una cravatta sgargiante scegliendo l’aggettivo giusto o il termine raffinato: questo è soltanto formalismo, e non è nemmeno elegante. Non devi far vedere che sai scrivere. Quando mi commissionano un lavoro li benedico sempre! Innanzitutto perché quando nasce e parte un progetto preciso si è più sicuri che verrà realizzato davvero. In fondo all’artista non interessa l’argomento. In letteratura, per esempio, una storia serve da pretesto. Allo stesso modo, un architetto nel progettare una casa trova il proprio pretesto per creare un’opera estetica. Ma la sua creazione dovrà rispondere a più funzioni, prima fra tutte quella sociale: nel progetto non dovrà tener conto soltanto delle sue velleità artistiche e delle richieste avanzate da chi abiterà l’appartamento, ma anche delle relazioni con il contesto esterno e con il paesaggio, secondo una coscienza civile che non sempre corrisponde a quella del committente. Infatti c’è un diffuso disinteresse verso gli altri e poco senso civico: basti vedere la poca attenzione con cui trattiamo ad esempio la raccolta differenziata, la difesa del territorio, il risparmio energetico… sembra proprio che le scelte fatte in ragione di un interesse generale e superiore non rientrino nella nostra cultura piccolo borghese, cattolica e bigotta.
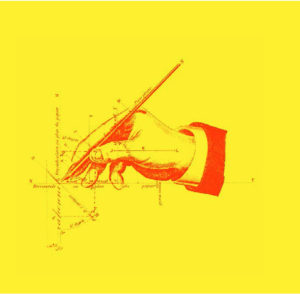
Parlando di scrittura su commissione, penso alla figura del copywriter.
In questo caso, più che di scrittori possiamo parlare di “creativi”. Li riconosci anche da come si vestono, hanno un senso forte della comunicazione, sono talentuosi e coraggiosi. Ricercare lo slogan è altra cosa che ricercare la parola. ad esempio, l’idea della famosa scena della staccionata saltata da Castelnuovo nella pubblicità dell’Olio Cuore è mia. avevano inventato quest’olio di mais che faceva bene, era da comprare quasi in farmacia. Il mercato era coperto, ma c’era l’esigenza di allargarlo: doveva diventare un olio che non facesse pensare per forza a un prodotto curativo. Uno slogan deve rispettare dei parametri che non sono scelti dal creativo ma dettati dal mercato: ho bisogno di conquistare questo spazio, allora tu trovami come fare, proponimi uno slogan geniale. Credo però che questo modo di lavorare non esista quasi più. La tecnologia ha penalizzato molto i creativi: gli spot che vedo ora si basano quasi esclusivamente sugli effetti speciali, il digitale, la postproduzione. E pensare che una volta, per riprendere un particolare tramonto che facesse da sfondo al prodotto reclamizzato, si spendevano miliardi.
Il messaggio è sempre più sbilanciato, i clienti sembrano spaventati da testi che richiedono un tempo di lettura superiore alla frazione di secondo…
Il progresso tecnologico ha prodotto in tutti noi una maggiore velocità nell’apprendimento e nella percezione delle cose. Se in un qualsiasi film degli anni Settanta le sequenze erano calme e “sedute”, in una pellicola dei nostri giorni – soprattutto in quelle americane – tagli e inquadrature durano al massimo quattro o cinque secondi. E questo vale anche per i libri: non ne esistono quasi più con le descrizioni, mentre nell’Ottocento i libri ne erano ricchissimi, perché i lettori non viaggiavano e leggere era un modo per vedere il resto del mondo, per conoscere orizzonti lontani. oggi viaggiano tutti e le descrizioni tendono a sparire del tutto. C’è da dire che il vero messaggio non è mai quello diretto. Soprattutto in pubblicità, un mondo che conosco perché ci ho anche lavorato. Devi conservare un messaggio segreto: dietro a quello espresso in maniera diretta, ce n’è sempre un altro. Prendiamo un classico esempio, quello dell’immagine pubblicitaria di una bella donna accanto a una macchina: il messaggio nascosto è che la macchina è bella come la donna. Ricordo una pubblicità paradossale della Volkswagen in cui un Maggiolino veniva spinto giù da un grattacielo di New York e una ripresa al rallenty seguiva la caduta dell’auto fino al suo impatto a terra, dove si riduceva in mille pezzi. Lo slogan dello spot recitava: «Chi l’ha detto che le Volkswagen non si rompono mai?» Chiaramente il vero messaggio è un altro e sta lì dietro per sorprenderti: per distruggere un Maggiolino devi buttarlo da un grattacielo. Il copywriter aveva assunto un punto di vista strategico, in linea con i precisi obiettivi di comunicazione dell’azienda.
Che livello di capacità narrativa rilevi oggi nella comunicazione delle imprese italiane?
Prima di distinguere tra i messaggi, è necessario distinguere tra i diversi mezzi di comunicazione. E oggi sia il marchio d’impresa che lo slogan per lanciare il prodotto sono molto condizionati dal mezzo televisivo. Come insegna McLuhan, il mezzo è il messaggio: il segno del messaggio cambia di senso in base al contesto in cui viene inserito. In questo periodo di crisi le uniche pubblicità che si vedono sono quelle delle automobili. Sono così tante e si somigliano un po’ tutte, il che è paradossale perché se una pubblicità non resta impressa nella memoria non assolve alla sua funzione principale.
In passato la pubblicità costava tanto, ora costa meno: dura di più e se la possono permettere anche i singoli esercizi commerciali. La tendenza è quella della recita da sitcom: cose lunghe e un po’ sciatte. Mentre bisognerebbe tenere alta la comunicazione, perché in un contesto sublime anche il prodotto diventa sublime. Un tempo se i caroselli erano brutti non venivano passati. Adesso i grandi numeri vengono dai prodotti più sciatti, non da quelli migliori.
[english]
You have, in the past, said that the art of writing is nothing more than the art of telling about yourself using language. After having mastered every skill of writing, what does writing mean to you?
To answer this I have to share a very personal story with you, that is, how I discovered writing and why, one fine day, I decided to become a writer. When I was little, I had some physical problems which, thankfully, healed with time. However, when I was ten I was really neurotic and aphasic. I didn’t fit in with the others and so I was always off somewhere on my own. That doesn’t mean I was sad or depressed about my solitude, on the contrary. In order to entertain myself I made up stories as I wandered around the streets of Ciampino, I invented tales in which I, of course, was always the hero, I who was victorious, a real star. All of this came from the deepest recesses of my imagination and when I saw the same thing once in my young son I was taken aback and reminded of my secret past.
In high school Pasolini was my literature teacher for three years. He was only twenty eight years old then, a young teacher who dressed as we did only with a tie, an old and worn out one because he was so poor. We felt closer to him because of this and I projected all of my need to be “saved” on him. Perhaps, who knows, he may even have been a sort of father figure for me. I wanted to seek him out; I needed contact with him, to tell him of me. I wanted him to know that I was neither aphasic nor neurotic, but, alas, I sat in the last row to hide and didn’t even respond during roll call. There was so much I wanted to tell him, but I couldn’t. He was everyone’s teacher, not my psychoanalyst. Then one morning I had the chance: he wanted us to write an essay – something teachers no longer do nowadays, even though I hear it may be coming back – on the theme “A day in the mountains”. He had no idea if any of us had even ever been in the mountains. I started writing in the big notebook he asked us to use and which he called “the conditioned reflex notebook”. That is how I began writing, and I still remember exactly how incredibly excited I was: I could finally talk to him! We would be alone together, just he and I, even though I would not be there physically, I would be there through the written word. But the theme was not “tell me about yourself ”, it was about a trip to the mountains. That meant that I would have to tell him something about myself (without knowing exactly what) indirectly, by talking about other things. So I invented a story that took place on Mt. Terminillo, with me as the strong and confident protagonist that fended off attacks by yetis, battled with snakes and commanded avalanches, as the one that ruled the world. That night I had trouble sleeping as I wondered what he was thinking about me: “the boy is quite mad”, for example, or “he’s an egomaniac”. And so I rewrote the entire essay and, in doing so, perhaps found my voice. The setting of this story was a summer Sunday; there were cow patties everywhere and big horseflies all around… I expressed extreme boredom dotted with some comic scenes: I knew he liked to laugh. I added details to make it seem as if I had actually been on Mt. Terminillo. It was then that I began to discover literature which, up to then, I had not known. Pasolini read my essay out loud to the class, slowly winding between the rows of desks. I was very surprised, excited and really happy, so much so that I couldn’t wait to write the next essay. Since then, to today – up until twenty minutes ago – I have spent my life writing the stories that my mind created, first as books, then I went on to poetry, then prose, movie and play scripts, even cartoons. What does literature mean to me? It is a way of talking about myself by writing about other things. And this, if you will, is the fate of those who live a psychodrama.
(Tratto da/from: NB. I linguaggi della comunicazione, Il valore dell’impresa, N.1, Anno IV, Logo Fausto Lupetti Editore, Milano 2012.)

